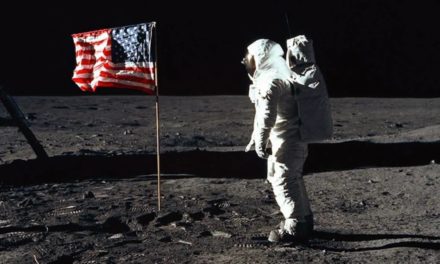Marco Tullio Giordana fotografato a Locarno dove è stato premiato con il LeoPardo d’oro alla carriera
È il 1972. A Parigi un giovane milanese di 22 anni esce disperato dalla mostra di Francis Bacon. Convinto di diventare un grande pittore, si rende conto che, al massimo, potrà essere solo una sua brutta copia. È senza speranze. Pensa perfino di gettarsi da un ponte nella Senna. Intanto s’imbatte in un grande trambusto. Stanno girando Ultimo tango a Parigi: vede anche Marlon Brando. Non si avvicina, per paura di essere allontanato. Resta però affascinato ad ammirare il lavoro di regista, attori e tecnici. Scocca in quel momento la scintilla che lo porterà ad appassionarsi di cinema e, nel tempo, a diventare uno dei più celebrati registi italiani. Pochi anni dopo l’avventura di Parigi, esattamente nel 1980, vince a Locarno il Pardo d’oro per Maledetti vi amerò. Quel pittore mancato ne ha vinto un altro, due settimane fa, attribuitogli alla carriera, dopo aver presentato a Locarno La vita accanto.
Marco Tullio Giordana, 74 anni il prossimo 1° ottobre, ha realizzato un film tenebroso (l’ha definito così lui) con una mano poetica (lo sostengo io) perché rende temi difficili in modo profondo e sognante, confezionando un film duro ma delicato. Perché lui è una persona delicata, parla con un filo di voce anche se è un omone dalle idee nette e dallo sguardo intenso che incute soggezione.
È la storia di Rebecca, nata con un vistoso angioma che le deturpa il volto e per questo rifiutata dalla madre che neanche la prende in braccio. La malattia apre squarci di intolleranza a vasto raggio nella città di provincia, Vicenza appunto, che fa da scenografia al film. Il lavoro di Giordana tocca temi intimi della vita di tutti: la vergogna, l’accettazione del diverso, l’ipocrisia, l’emarginazione dalla comunità, l’umiliazione, la religione, la famiglia lacerata.
Tratto dal romanzo d’esordio di Mariapia Veladiano nel 2011, assai lodato e premiato, il film è ambientato a Vicenza tra il 1980 e il 2000 ed è stato presentato, grazie a Erico Ladisa direttore dell’Odeon, ai chiostri di Santa Corona in anteprima nazionale: 500 persone ad assistere, 200 rimaste fuori ad attendere la miracolosa materializzazione di un biglietto.
Maestro…
…sa cosa rispondeva Monicelli quando lo chiamavano così: Maestro de che?
Come vuole. Certo che lei già dal nome incute reverenza: dopo Cicerone lei è il secondo Marco Tullio illustre. Si vede che i suoi genitori amavano molto il latino
In realtà avevo un nonno che si chiamava Carlo Tullio. Il suo nome sarebbe toccato a mio fratello maggiore che invece è diventato Franco. Papà voleva Tullio perché quando sono nato il nonno era appena mancato, ma a mia mamma non piaceva: ha scelto Marco accettando Tullio pensando che sarebbe caduto con il tempo. Invece è rimasto.
Tanto per restare nell’ambito del film, con un nome così importante magari ha avuto problemi di sfottò a scuola.
No, solo che gli insegnanti dicevano: ah, con quel nome tu sarai bravo in latino, vieni fuori che ti interrogo.
Un po’ l’ha pagato, insomma, il nome
Ma devo dire che con gli anni, piacendomi molto il latino e ancor più il greco, leggendo le opere di Cicerone ho scoperto che era un grandissimo scrittore: De amicitia, De senectute sono libri che andrebbero imposti a scuola.

La locandina del film “La vita accanto” con le tre protagoniste; Valentina Bellè, Beatrice Barison e Sonia Bergamasco
Passiamo al film. Lei ha detto: racconto la vergogna perché l’ho conosciuta di persona.
Credo che la vergogna sia il sentimento di ogni bambino. Vergognarsi dei propri genitori, dei propri pantaloni troppo lunghi o troppo corti, della giacchetta del fratello maggiore… Queste sono vergogne sociali. Poi c’è la vergogna del non sentirsi simile agli altri, diverso. Il sentimento dell’inadeguatezza quando si è molto piccoli è vergogna, poi assume caratteristiche più aggressive. La si nasconde diventando odiosi.
Nel film c’è questo dualismo fra amare e respingere: perché si scatenano questi sentimenti opposti a proposito della bambina macchiata e anche marchiata?
Non è una contraddizione, ma è l’ambivalenza di tutti i rapporti affettivi: per entrare in questo film bisogna ricollegarsi alla propria infanzia. È una chiave che lo rende più comprensibile. La bambina cresce con questo stigma della macchia rossa, raccontiamo come lo affronta lei e come lo affrontano tutti gli altri. Ho cercato di trasmettere quel senso continuo di minaccia che si prova da bambini…
Se la vicenda accadesse oggi anziché nel 1980 com è ambientata nel film sarebbe meglio o peggio?
Sarebbe uguale. Oggi è considerato uno stigma il naso che non è uguale a quello dell’attrice, il seno troppo grande o troppo piccolo. Sono rilevanti tanti aspetti esteriori dettati dai modelli del consumo e della pubblicità, che creano disturbi anche molto gravi. A pensarci bene, oggi sarebbe anche peggio di 40 anni fa.
Cosa le ha insegnato Bertolucci che lei considera il suo regista di riferimento assieme a Marco Bellocchio?
Direttamente niente: ho avuto con lui grande amicizia e tenerezza, abbiamo discusso molto di cinema, certo. Quello che vedevo in lui – e che non so se ho raggiunto in tutti questi anni – è il suo amore sconfinato per il cinema che non è mai venuto meno. Trattava il cinema come fosse una fidanzata appena incontrata, malgrado fossero passati tanti anni. Non era diventato un matrimonio, il suo, con gli elementi di sopportazione, di noia, di accomodamento. No, era innamorato del cinema come se fosse stato folgorato da una ragazza che vedi e le dici: voglio deporre il mio cuore ai tuoi piedi. Ti sorprendeva sempre.
La meglio gioventù è un verso di Pasolini che lei ha trasformato nel titolo di un suo film: una parola per definire Pasolini, poeta che lei ha molto amato
Lui davvero potrei chiamarlo maestro, perché per me lo è stato anche se non l’ho mai conosciuto. È stato un esempio di coerenza, integrità, di chi non vuole mai soccombere al desiderio di compiacere gli altri, di piacere. Peccato non ci sia più.
Cos’è la famiglia per lei?
È il senso di sentire che scorre lo stesso sangue, cosa che però non protegge dai conflitti, dalle incomprensioni, dalle insofferenze. Che – devo dire – sono più forti quando si è figlio. Diventando padre cessano le insofferenze, è più importante la comprensione.
C’è una vita accanto di cui non ci accorgiamo perché siamo diventati distratti o superficiali?
Chissà quante ce ne sono, due o tre.
Diventerà mai pittore?
Ma io continuo a disegnare! Lo facevo sin da piccolo e proseguo ora. Pensi che ho ritrovato dei disegni conservati da mia madre, tra cui un bellissimo scimpanzé ad acquarello – di cui m’ero totalmente dimenticato – che disegnai a tre anni. Se uno lo guarda esclama: “Questo bambino diventerà un grandissimo pittore”. Tutti erano convinti in famiglia che fosse il mio destino. Poi ho visto Bacon e ho capito che non lo sarei mai stato.
Cinema e pittura hanno un linguaggio simile?
Hanno parentele, ma il linguaggio è molto diverso. Nella pittura la figura umana è fissata in una dimensione bidimensionale e deve attrezzarsi di un valore simbolico – narrativo che invece il cinema può sviluppare senza problemi.
Cosa c’è del pittore Giordana nel regista?
È istintivo cercare la sezione aurea dell’inquadratura, soppesarla, il che forse non deriva dall’essere stato un pittore ma dall’aver ammirato molti quadri, da stare molto nei musei.
Il suo cinema come lo definirebbe: che so impegnato si sarebbe detto una volta, esistenziale…
Io non faccio cinema, faccio dei film.
Ah, lei non fa cinema?
No, è un’espressione che io odio. Il mio cinema… Quando la sento dire dai colleghi dico “Ahi…”
Cosa fa allora?
Dei film, uno dietro l’altro. Sembra che debbano essere governati dalla coerenza, ma non è così.
Non c’è un filo che li unisce?
Non lo so e non m’interessa proprio per nulla saperlo. Di volta in volta c’è qualcosa che ti tocca e vuoi raccontare. Soprattutto le storie e i personaggi.
Che cos’è la religione per uno come lei che è – ha detto – felicemente ateo?
Lo sono dall’età di cinque anni
Se lo ricorda?
Certo, scoprii che i miei genitori mi avevano ingannato perché non esisteva Gesù Bambino ed erano loro che mettevano i regali sotto l’albero. Da quella volta mi sono sentito truffato e ho chiesto anche l’esenzione dalla messa.
Parliamo di quasi settant’anni fa. Non era semplice come richiesta, soprattutto a quei tempi.
Ma i miei furono colpiti da questo discorso e risposero: va bene, deciderai quando sarai grande.
A lei che ha raccontato il Paese nelle sue generazioni da sessant’anni in qua la domanda è d’obbligo: che futuro ha l’Italia? Si può essere ottimisti o siamo condannati al pessimismo?
Siccome io sarei inguaribilmente pessimista, non voglio rispondere a questa domanda.
Ma c’è qualcuno in cui aver fiducia?
È perfino banale dirlo: i bambini. Lo sosteneva Elsa Morante che il mondo sarà salvato dai ragazzini. Sono ancora puliti.
D’accordo. Ma se ci guardiamo intorno c’è una persona, secondo lei, che può darci fiducia?
Aborro qualsiasi tipo di impegno politico, non voglio neanche conoscerli i politici. C’è però una persona che ammiro e seguo e se mi chiede di fare qualcosa la faccio: don Ciotti. Lui lo ammiro veramente e non mi ha mai deluso.
Lei ha detto: potrei fare a meno del cinema ma non della musica.
Preferirei non fare a meno di nessuno dei due. Dovendo scegliere, la musica mi dà troppa gioia e commozione.
In questo film lei ha voluto pianisti autentici perché quando suonano – ha spiegato – i musicisti hanno dipinti in viso momenti di felicità quasi orgasmica.
Proprio perché l’inganno è la cosa che mi ha talmente ferito da bambino da non credere più in nulla, penso che in un film se mostri un attore che suona lui deve saper suonare. Fare lo stacco dalle mani che suonano al volto di un altro mi sembra una truffa.
E ha scelto Sonia Bergamasco e Beatrice Barison, che è una concertista di fama.
Sonia aveva una carriera meravigliosa da concertista che lei ha buttato alle ortiche per dedicarsi al teatro e al cinema. Non dispero che lei torni alla musica, intanto le metto delle piccole trappole.
Trappole?
Le ho chiesto di suonare Rachmaninoff e lei ha protestato: ma no, è troppo difficile… Così è stata costretta a studiare.
Lei stato grande amico di Vittorio Mezzogiorno.
Era mio fratello.
Sua moglie Cecilia era vicentina
Come no, figlia di Filippo Sacchi il padre dei critici cinematografici italiani. Mi mancano molto tutti e due. Li ho sempre visti come una cosa sola. Vittorio era un grande amico e un attore straordinario. Forse il suo film più bello è stato Il Mahabharata di Peter Brooke. Faceva la parte di Arjuna, l’eroe, perché lui era un uomo di altri secoli, antico. Era un vero eroe.
Lei ha scoperto anche tanti talenti giovani: come fa, cosa la colpisce? Lo studio, la recitazione…
Intanto li cerco, perché molti neanche li cercano. Mi piacciono i giovani attori che abbiano una formazione teatrale, perché dà loro peso. Come faccio? Vedo in loro qualcosa che mi sembra evidente.
Evidentemente non a tutti. Lei ha detto che proprio Vittorio Mezzogiorno le suggerì di badare più agli attori che non alla camera nei film.
All’inizio quando ci conoscemmo lui non si trovava bene, perché io ero molto innamorato della macchina da presa, sull’esempio dei grandi versificatori del cinema, alla Orson Welles e lo stesso Bertolucci. Ma lui mi avvertì: chi trasmette le emozioni sono gli attori – mi spiegò – Se tu li metti in difficoltà con le tue evoluzioni e non possono scavare, sbagli: potresti avere molto di più da loro.
E aveva ragione?
Totalmente. E infatti tutti pensano che nei miei film la macchina da presa sia fissa, invece è sempre su un carrello è sempre su un binario, ma nessuno se ne accorge perché lascio spazio agli attori.
A proposito di grandi, lei ha conosciuto Fellini?
Poco, ma ho fatto un film con la sorella, Maddalena, che gli assomigliava molto. Lui, che non vedeva mai i film, il mio lo vide e poi mi chiamò. Io pensavo che fosse uno scherzo di qualche amico, invece era lui. Si complimentò e aggiunse: anche Maddalena è brava, chi l’avrebbe mai detto. Era un grande incantatore, un grande impostore, una delle persone più seducenti che abbia mai incontrato e forse una delle persone più intelligenti che abbia mai conosciuto. Se si leggono le sue interviste, che sono sempre vagamente reticenti e oblique, spesso divaga, ma sono sempre geniali.
Cosa le manca di raccontare?
Ho i cassetti pieni di progetti. Qualcuno non si può realizzare più perché accade di disamorarsi anche delle proprie idee, di trovarle ingiallite. C’è però una storia degli anni Settanta che ho scritto con Lirio Abbate, giornalista d’inchiesta, che si chiama Il rosso & il nero. Racconta di due ragazzi, uno di destra e uno di sinistra, che si conoscono in carcere e diventano paradossalmente amici e fedeli l’uno all’altro. L’abbiamo scritto quattro o cinque anni fa: siamo stati molto preveggenti. Se va bene La vita accanto spero di metterci le mani.
Cosa le resta di Vicenza dopo questo film?
Sono stato accolto benissimo. Nella scena del concerto al teatro Olimpico devo dire che gli attori – non voglio chiamarli comparse – sono stati eccellenti. Non sapevo, oltretutto, che Vicenza avesse questo meraviglioso nuovo teatro. Io l’ho trasformato nel teatro di Tel Aviv nel film ma nel vostro teatro con le mie tre attrici (Sonia Bergamasco, Valentina Bellè, Beatrice Barison, ndr.) vorrei allestire le Tre sorelle di Cechov.
Antonio Di Lorenzo